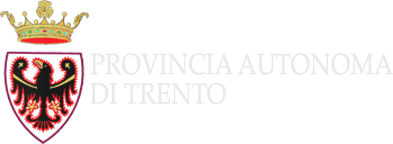Industria idroelettrica e Autonomia in Trentino
Interviene Tommaso Baldo. Introduce Massimo Libardi.

L'industria idroelettrica trentina nacque nell'ultimo decennio del diciannovesimo secolo dall'impegno delle amministrazioni comunali e delle cooperative. Con l’annessione al Regno d'Italia e l’instaurazione del regime fascista lo sfruttamento delle acque trentine venne affidato alle grandi imprese elettrocommerciali private che agivano in regime di oligopolio, cioè imponendo alte tariffe ai consumatori e senza tener conto delle esigenze delle comunità locali.
Nell’estate del 1945 iniziò in Trentino il dibattito che porterà alla conquista del primo Statuto d’Autonomia. Inevitabilmente il dibattito sull’autonomia era destinato a divenire anche un dibattito inerente la gestione della principale risorsa del Trentino: l’acqua necessaria alla produzione di energia idroelettrica, una ricchezza indispensabile per un paese povero di fonti energetiche e impegnato in una difficile ricostruzione post bellica.
Con l’approvazione dello Statuto d’autonomia della Regione Trentino Alto-Adige nel 1948, nonostante il riconoscimento della potestà legislativa della regione o delle province in numerose materie, lo Stato italiano mantenne il controllo del patrimonio idrico trentino, considerato una risorsa strategica, la cui proprietà fu negata alla Regione. Ad essa fu riconosciuta solo una competenza di tipo concorrente con lo Stato in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Ciò avvenne nel quadro di una sostanziale continuità, durata fino alla nazionalizzazione del 1962, con le politiche del fascismo in materia di energia, ovvero con la difesa dei privilegi concessi ai gruppi monopolistici elettrocommerciali.
Questi ultimi poterono intraprendere la costruzione dei grandi impianti già progettati, a cominciare da quelli di Santa Giustina (proprietà Edison) e Santa Massenza (proprietà SISM, cioè Edison e IRI). Grazie a queste nuove opere l’industria idroelettrica in Trentino-Alto Adige assunse un peso di primaria importanza nel contesto italiano; nel 1959 ad esempio gli impianti idroelettrici in regione producevano il 15,5% dell’energia elettrica prodotta in Italia.
Lo Statuto accoglieva però al contempo le richieste più essenziali e “pratiche” avanzate dagli amministratori trentini: stabiliva in particolare che le popolazioni locali avevano diritto a una “compensazione” (sotto forma di energia disponibile a prezzo di costo e della tassa di 10 centesimi il kwh) per l’utilizzo a scopo idroelettrico dei loro corsi d’acqua, dava la facoltà alla Regione autonoma di presentare le proprie ragioni al Ministero dei lavori pubblici riguardo alle concessioni di derivazioni idroelettrica e soprattutto stabiliva che la Regione stessa potesse impegnarsi nel settore, che fosse anzi favorita, a parità di condizioni, nell’assegnazione di derivazioni a scopo idroelettrico.
Era esattamente quello che occorreva perché la SIT, l’azienda elettrica controllata dal comune di Trento, con il supporto dell’ente Regione, potesse diventare un’azienda elettrica capace di fare concorrenza alle grandi imprese nazionali e di garantire l’autonomia energetica del Trentino.
A questo quadro occorre aggiungere un’analisi delle condizioni di lavoro nei cantieri idroelettrici, spesso assai dure. Non a caso i lavoratori impegnati nella costruzione delle maggiori centrali furono tra gli anni Quaranta e Cinquanta i più radicali e combattivi nel contesto trentino.
ingresso libero fino ad esaurimento posti
organizzazione: Biblioteca Archivio del CSSEO, Fondazione Museo Storico del Trentino