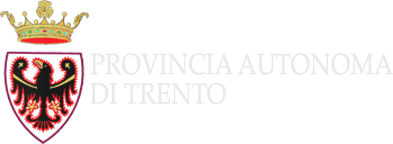L'Islam in Cecenia e nel Caucaso
Mercoledì 3 marzo, alle 17,30, a Trento, nella Sala del Centro Bernardo Clesio (via Barbacovi 4) il Centro Studi sulla Storia dell'Europa Orientale organizza la quinta conferenza del ciclo "Le molte facce dell'Islam radicale e dei fondamentalismi".
Giovanni Bensi interverrà su "LIslam in Cecenia e nel Caucaso". Introduce Fernando Orlandi.
Giovanni Bensi, membro fondatore del nostro centro studi, ha lavorato per molti decenni a Radio Liberty, lemittente che trasmetteva in lingua russa prima da Monaco di Baviera e poi, dalla metà degli anni Novanta, da Praga. Da Radio Liberty, oggi Giovanni Bensi va in onda come commentatore speciale, mentre segue le vicende della Russia per lAvvenire. Scrive anche per il quotidiano moscovita Nezavisimaya gazeta. Ha pubblicato diversi libri e sta pre licenziare una monografia sul Caucaso.
La regione caucasica è oggi di particolare attualità a causa della guerra in Cecenia e della sua importanza geopolitica e geostrategica, essendo ricca di petrolio a teatro di una concorrenza internazionale (in particolare fra USA e Russia) per i tracciati degli oleodotti. L'Islam non è la sola religione presente nel Caucaso: nelle tre repubbliche indipendenti della regione, Azerbaigian, Armenia e Georgia prevalgono tre religioni, o confessioni, differenti, rispettivamente l'Islam sciita, il cristianesimo monosfisita e quello greco-ortodosso.
L'Islam come fattore non solo religioso, ma anche politico, svolge un ruolo particolare nel Caucaso del Nord, in Cecenia e Daghestan, soprattutto, ma anche in Adygheja, Karaciaj-Circassia, Kabarda-Balkaria, Inguscezia, un po' meno in Ossezia del Nord (tutte repubbliche autonome nell'ambito della Russia), e poi in Abkhazia e Adzharia (repubbliche autonome della Georgia).
L'islamizzazione del Nord-Caucaso ha proceduto lentamente, dall'VIII al XIX sec. L'Islam di questa regione ha profondi legami con l'Asia Centrale, l'Afghanistan e l'India. Una sua caratteristica è la presenza predominante delle tariqat, le "scuole" mistiche, o "sufiche". Due svolgono un ruolo particolarmente importante, la "Naqshbandiya" e la "Qadiriya". La prima proviene da Bukhara (Asia Centrale), la seconda da Baghdad. Entrambe hanno però subito l'influenza del misticismo islamico indiano. Caratteristica delle tariqat è il rapporto di stretta sottomissione fra il "murshid" (maestro) e il "murid" (discepolo). Questo rapporto ha avuto, specialmente in passato, un'importanza politica perchè era in grado di influenzare verso questo o quel partito larghi strati dell'opinione pubblica musulmana. L'ideologia che ne deriva è spesso indicata col termine "muridismo".
Il "muridismo" ebbe una funzione essenziale durante la lunga guerra che dal 1817 al 1864 fu combattuta dai russi contro gli insorti nord-caucasici. Durante questa guerra, sotto la guida dell'imam Shamil, si costituì in Cecenia e Daghestan uno stato islamico (imamato) considerato per quei tempi "progressita". Shamil fu sconfitto dai russi e mandato in esilio alla Mecca, dove non arrivò perchè morì durante il viaggio. Shamil elaborò la dottrina del "jihad" ("guerra santa") che però per lui, in accordo con il Corano, era soprattutto combattimento spirituale: per indicare la lotta armata contro gli "infedeli" egli introdusse il termine "ghazawat". A Shamil si contrapponeva lo sheikh Kunta-Haji Kashiev che invece predicava la pacifica convivenza con i russi a patto che questi rispettassero le tradizioni culturali e religiose dei ceceni.
Se la "guerra caucasica" del XIX sec. fu la prima esperienza traumatica per i popoli nord-caucasici, la seconda fu la loro deportazione in massa nel 1944 per ordine di Stalin che li accusava di slealtà durante la Seconda guerra mondiale. Furono deportate, sotto la regia di Laventij Berija, oltre 600.000 abitanti del Caucaso del Nord, compresi 490.000 ceceni e ingusci. I superstiti poterono tornare solo dopo il XX Congresso del PCUS nel 1956.
La "guerra caucasica" del XIX sec. e le deportazioni del 1944 costuiscono il substrato storico e psicologico dell'ostilità dei ceceni verso i russi, del loro separatismo e delle due guerre cecene del periodo post-sovietico: quella del 1994-1996 e quella iniziata nel 1999 e tuttora in corso. Nella prima di queste guerre (periodo di Dzhokhar Dudajev) prevaleva il fattore nazionale di contrapposizione ai russi, anche se non mancavano le motivazioni islamiche. Nella seconda guerra invece il fattore islamico è balzato in primo piano con un effetto di internazionalizzazione del conflitto. Sono comparse correnti estremistiche, prima estranee al Caucaso, primo fra tutti il "wahhabismo". Esso proviene dall'Arabia Saudita (dove è la corrente dominante) e si formò alla fine del XVIII sec. come movimento "purista" o di "ritorno all'antico" ("salafita"), sul piano religioso, e di resistenza alla dominazione ottomana sul piano politico. I "wahhabiti" respingono come "bid'ah" ("innovazione") tutto ciò che nell'Islam è avvenuto dopo Maometto e i primi quattro califfi. Sono contrari al "sufismo" e al culto dei "wali" ("santi"), pratiche invece assai popolari nel Nord-Caucaso. Ideologicamente si ispirano all'egualitarismo e alla "democrazia guerriera" dei beduini del deserto. Un'altra corrente estremistica infiltratasi nel Caucaso del Nord è quella di bin-Laden e "al-Qa'idah", con la quale hanno rapporti sia Shamil Basajev, il leader più fondamentalista della guerriglia cecena, sia, fino alla sua morte in un attentato nel Qatar il 13 febbraio, Zelimkhan Jandarbiev, già per un certo tempo presidente della Cecenia secessionista. "Wahhabiti" e seguaci di bin-Laden sono però in conflitto tra loro: mentre i primi cpmbatterono i califfato ottomano nel 1918 e considerarono una loro vittoria la sua caduta, bin-Laden ritiene la sconfitta della Sublime Porta il primo passo dell'"umiliazione" a cui l'Occidente sottoporrebbe senza sosta il mondo islamico. L'intromissione di "wahhabiti" e "al-Qa'idah" nella guerra cecena ha favorito il suo slittamento verso i terrorismo come hanno dimostrato episodi anche recenti.
organizzazione: CSSEO Centro Studi sulla Storia dell'Europa Orientale