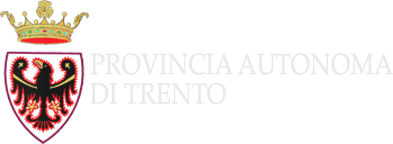Le bombe dell’Alto Adige
Marco Boato e Giorgio Postal discutono con Paolo Morando, autore di Le bombe in Alto Adige

Almeno 361 attentati con esplosivi, armi da fuoco e mine antiuomo (ma nessuno ha mai prodotto un regesto completo…). Ventuno morti, di cui 15 uomini delle forze dell’ordine, due cittadini e quattro terroristi dilaniati dagli ordigni che loro stessi stavano predisponendo. E poi ancora: 57 feriti, di cui 24 tra le forze dell'ordine
Diciassette sono state le sentenze passate in giudicato. La magistratura italiana ha condannato 157 persone, di cui 103 sudtirolesi, 40 austriaci e 14 tedeschi. Una parte dei condannati ha trovato rifugio all’estero, oltre il Brennero, in uno stato che li ha protetti e respinto le richieste di estradizione.
Gli attentati iniziano nel settembre del 1956 e nel gennaio dell’anno successivo nel mirino entrano le linee ferroviarie. In breve tempo si individuano i responsabili: il cosiddetto “Gruppo Stieler”, capeggiato da Hans Stieler, tipografo del quotidiano Dolomiten. Friedl Volgger, condirettore del giornale e vicepresidente della SVP (Südtiroler Volkspartei), viene indicato da Stieler come lo sponsorizzatore. L’accusa, tuttavia, non sarà mai provata e dopo un’ottantina giorni di detenzione viene scarcerato e prosciolto in istruttoria.
Viene poi costituito il Befreiungsauschuss Südtirol, il Comitato per la liberazione del Sudtirolo, che firmò la prima grande stagione del terrorismo, prima di essere decapitato dalle forze dell’ordine. Terrorismo da una parte e una reazione violenta delle forze dell’ordine: denunce di torture da parte dei detenuti, suffragate da referti medici. Il 22 novembre 1961 muore nel carcere di Bolzano Franz Höfler, uno dei detenuti che avevano accusato polizia e carabinieri di brutalità. Il successivo 7 gennaio, sempre in carcere muore Anton (Toni) Gostner. Dieci carabinieri vengono rinviati a giudizio, ma la Corte d’Appello di Trento ne assolve otto e amnistia gli altri due, esacerbando il clima in Alto Adige. Il generale De Lorenzo li encomia.
La notte tra l’11 e il 12 giugno 1961 era quella in cui si accendevano in Alto Adige gli Herz-Jesu-Feuer, i “fuochi del Sacro Cuore”, falò a ricordo della vittoria di Andreas Hofer sulle truppe francesi napoleoniche. Quella notte, un’ora dopo la mezzanotte del 12 giugno 1961 ci fu un’esplosione nel centro di Bolzano, seguita nelle due ore successive da altre 46 che abbatterono decine di tralicci dell’alta tensione in tutta la provincia. L’ingente quantitativo di esplosivo utilizzato era arrivato dall’Austria.
Questa imponente serie di attentati fu opera del Befreiungsausschuss Südtirol, costituito nel 1956 per opera di Sepp Kerschbaumer, che propugnava l’autodeterminazione dell’Alto Adige, la secessione dall’Italia e l’annessione all’Austria al fine di ottenere l’unificazione politica del Tirolo.
La reazione dello Stato, che temeva una vera e propria guerra civile, è direttamente proporzionale alla portata dell’avvenimento, mentre per la prima volta la SVP si schiera apertamente contro i dinamitardi. Da parte sua, lo Stato italiano mostra i muscoli. A Bolzano, sette alberghi vengono requisiti e trasformati in caserme, arrivano i battaglioni mobili e viene costituita la scuola per allievi agenti di polizia. Il presidente del consiglio Amintore Fanfani impone il coprifuoco e l’obbligo del visto d'ingresso per gli austriaci che vogliono entrare in Alto Adige.
Scattano gli arresti. Quasi tutti gli arrestati coinvolgono altre persone, così che nel giro di poche settimane circa 150 presunti attentatori finiscono in carcere. Confessioni ottenute grazie alle torture? La polemica è viva ancora oggi.
Queste vicende, fino all’ultima stagione terroristica di Ein Titol, sono rivisitate nelle complesse dinamiche (relazioni internazionali, l’attuale autonomia regionale, ruolo degli apparati dello Stato e via di seguito) in “Le bombe in Alto Adige”, ultimo lavoro di Paolo Morando. Tra i tanti, in questo agile lavoro, l’autore ricorda l’importante testamento di Luis Amplatz, depositato presso un notaio di Vienna circa un mese prima di essere ucciso a Malga Saltusio, in Val Passiria.
Amplatz rievoca le diverse conversazioni preliminari (anni 1959-60) con importanti personaggi politici austriaci. Le prime si svolsero con il giornalista Wolfgang Pfaundler, che li mise in contatto con il giornalista, saggista, editore e diplomatico Fritz Molden, recentemente deceduto a Schwaz, nel Tirolo austriaco. Personaggio non di secondo piano, Molden: tra l’altro, nel 1987 venne incaricato dal governo austriaco di speciali missioni diplomatiche con l’obiettivo di risanare l’immagine dell’Austria, offuscata dal caso di Kurt Waldheim.
Secondo le rivelazioni di Amplatz, Molden si incaricò di fornire armi, “ottime armi”, e finanziamenti. Poi i colloqui proseguirono con interlocutori di più alto livello. Incontrarono varie volte Rupert Zechtl, esponente del Partito socialdemocratico austriaco e dal 1960 al 1975 consigliere regionale del governo tirolese, che settembre del 1959 propose ai terroristi di incontrare il compagno di partito e neo-ministro degli esteri Bruno Kreisky (1959-1966, e Cancelliere dell’Austria dal 1970 al 1983).
A Vienna si incontrarono con Franz Gschnitzer segretario di Stato al Ministero degli esteri e discussero delle imminenti trattative all’ONU; qualche settimana dopo incontrarono Kreisky: “Espressero il loro punto di vista e giocarono a carte scoperte”.
Il sostegno dello stato austriaco ai terroristi sudtirolesi (in anni successivi Kreisky fu il protagonista di un accordo con i terroristi palestinesi) deve ancora essere pienamente ricostruito, così come il tentativo di sostegno messo in atto dalla Státní bezpečnost, la polizia segreta della Cecoslovacchia comunista.