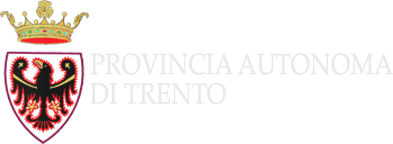Perline sul fondo
Il film che ha dato vita alla “Nová vlna” cecoslovacca
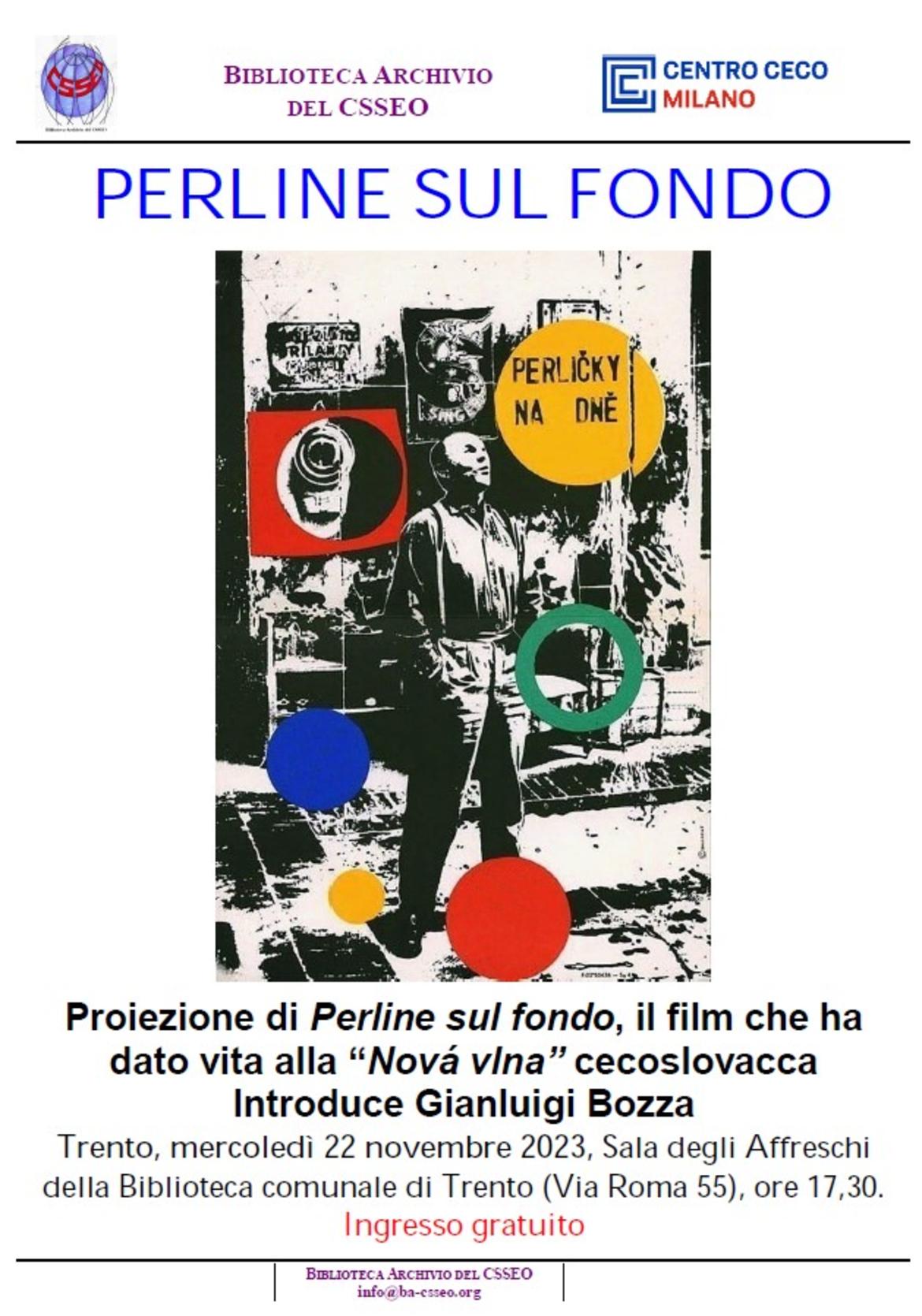
La destalinizzazione arriva tardi in Cecoslovacchia. Dopo la morte di Stalin, a Mosca avanza il “disgelo” e già nella primavera del 1953 vengono liberati i primi detenuti dai lager, ma a Praga non accade pressoché nulla. Neanche il cosiddetto “rapporto segreto” di Nikita Khrushchev al XX congresso del PCUS (febbraio 1956), si riverbererà in Cecoslovacchia. In Polonia, dopo Poznań, ci sarà l’ottobre, a sua volta detonatore della rivoluzione ungherese, schiacciata dall’intervento militare dell’armata rossa, che a sua volta destabilizzerà il movimento comunista internazionale.
Insensibili ai nuovi tempi, a Praga si proseguirono nella costruzione del più grande monumento a Stalin del mondo, inaugurato il primo maggio del 1955. Un’operazione cosmetica di revisione di qualche processo politico si ebbe nel triennio 1955-1957, affidata a Rudolf Barák, che all’organizzazione degli stessi processi farsa aveva preso parte. La momentanea apertura nella politica culturale della primavera del 1956 altro non fu che un fuoco fatuo. L’abbattimento del monumento a Stalin venne deciso solo nel novembre 1961, un mese dopo che la salma di Stalin era stata rimossa dal mausoleo nella Piazza rossa.
A smuovere le acque stagnanti furono gli scrittori nel 1963. Si affacciava sulla scena cultural-politica una nuova generazione e il passo fu breve dalla letteratura al cinema, anche per il ruolo svolto dalla Facoltà di cinema e televisione dell’Accademia di arte delle Muse (FAMU) di Praga. Sorge così la “Nová vlna”, la “nuova onda”, movimento originale, che non va appiattito sulla “Nouvelle Vague” francese. Anzi, spesso si scontreranno, come quando Luc Moullet stroncò “Diamanti della notte” di Jan Němec, per la sua “estetica reazionaria”. Il più critico fu Jean-Luc Godard, che accusò Věra Chytilová di copiare Michelangelo Antonioni e Arthur Penn, malevolmente accostandola alla casa di produzione Paramount. La difese Ivan Passer, che bollò il cinema di Godard come “piccolo borghese”. Secondo Antonin Liehm, alla base dell’incomunicabilità tra i due movimenti c’era una faccenda politica, dal momento che molti cineasti francesi erano seguaci del marxismo. La corrente cecoslovacca, che non si raccolse mai sotto un vero e proprio manifesto, testimoniava invece un carattere spontaneista.
Quelle realizzate dai cecoslovacchi sono spesso trasposizioni cinematografiche di opere letterarie, e i temi affrontati toccano aspetti della vita che in precedenza sarebbero finiti sotto la mannaia dalla censura. Il “realismo socialista” è gettato nel bidone dei rifiuti da questi registi (grosso modo trentenni) che inseriscono le loro esplorazioni in una prospettiva particolare, quella dello smantellamento sistematico delle illusioni veicolate dal potere totalitario. Al contempo rivelano un’attenzione particolare alla forma, cioè alla sperimentazione di nuovi modelli narrativi e rappresentativi, di un nuovo linguaggio filmico. Affermano la soggettività contro ogni falsa oggettività. Lo fanno scegliendo come chiave tutte le sfumature dell’ironia del grottesco, del surreale (secondo la grande tradizione letteraria che va da Jaroslav Hašek a Franz Kafka) e sovvertendo le strutture narrative convenzionali. Non imbastiscono intrecci, non raccontano storie e personaggi a tutto tondo ma osservano comportamenti e fenomenologie, raccolgono impressioni; il loro linguaggio è ellittico e composto di frammenti. E poi non usano quasi mai attori professionisti.
Questi registi erano legati tra loro da rapporti di collaborazione e di discussione, con una formazione comune alla FAMU. Siamo dinanzi ad una grande compenetrazione di letteratura e cinema, con gli scrittori che fanno gli sceneggiatori e partecipano alla realizzazione di film. Al IV Congresso dell’Unione degli Scrittori Cecoslovacchi del 1967, Milan Kundera parlerà del cinema del suo paese che vive “un’età dell’oro”, il “fenomeno più significativo della realtà ceca di questi ultimi anni”. E ottengono importanti riconoscimenti: al “Negozio al corso” (1965), diretto da Ján Kadár e Elmar Klos viene assegnato nel 1966 l’Oscar per il miglior film straniero. Due anni dopo lo riceve Jiří Menzel, cementando la reputazione del cinema cecoslovacco come uno dei migliori al mondo, per “Treni strettamente sorvegliati” (1966), trasposizione dell’omonimo romanzo di Bohumil Hrabal.
Pur non esistendo un manifesto della “Nová vlna”, possiamo considerare tale “Perline sul fondo” (“Perlickv na dne”, 1965), un film composto da cinque episodi tratti da altrettanti racconti di Hrabal, tratto dal suo primo libro pubblicato ufficialmente nel 1963 (e recentemente tradotto in italiano come “La perlina sul fondo”, Miraggi, 2020). I registi (Věra Chytilová, Jaromil Jireš, Jiří Menzel, Jan Němec, Evald Schorm) si trovavano in perfetta sintonia con i testi di Hrabal, rimanendo fedeli allo spirito dell’opera.
Questi racconti di Hrabal sdogananano nella letteratura ceca i “discorsi della gente”, l’inventiva linguistica e la creatività popolare di operai delle acciaierie, commessi viaggiatori, ferrovieri, assicuratori, notai, impiegati del macero della carta, macchinisti teatrali, che, attraverso un lessico colorito, espressioni dialettali e slang professionali, restituivano alle pagine dei libri la vivacità dell’osteria e “lo splendore dei chiacchieroni e il loro sollazzarsi”.
I personaggi di Hrabal, con la loro sregolatezza, pronti a perdersi per le strade di Praga o dietro all’amore di una bella zingara, si prestavano bene ad incarnare lo spirito della “Nová vlna”. La sua letteratura poco o niente ideologica era tuttavia profondamente “politica”. Non a caso sia Hrabal che i registi della “Nová vlna”, dopo l’invasione sovietica dell’agosto 1968 furono prima mal tollerati, poi censurati e infine emarginati dal regime della “normalizzazione”. L’invasione segnò la fine della “Nová vlna”; chi restò in patria si vide troncata la carriera, mentre altri decisero di prendere la strada dell’emigrazione.
Versione restaurata dalla Cineteca nazionale ceca. Introduce Gianluigi Bozza.